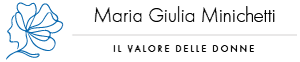La dipendenza. Un argomento vastissimo. E’ una forma di legame in cui non si vedono alternative: “Se non ho lui o lei non posso vivere. Non ce la faccio”.
Ma anche senza quel cibo, quella sostanza, quell’abitudine, senza quel sintomo, perfino. Non si riesce ad essere autonomi, a pensare, a decidere, a vivere senza la presenza dell’altro.
Ma la dipendenza non è necessariamente negativa. Dipende nei confronti di “chi” o cosa siamo dipendenti. I nostri polmoni sono dipendenti dall’ossigeno, il nostro corpo dall’acqua, siamo dipendenti da piccoli dal grembo della mamma che ci nutre e ci sostiene. Possiamo essere dipendenti da un “maestro”, da una disciplina, da una relazione che ci fa crescere ed evolvere. L’importante è accorgersi quando e se questa dipendenza comincia a limitarci perché limitarsi significa già fermarsi e regredire.
Quella di cui si parla di meno è invece la dipendenza nelle relazioni di aiuto. Non solo quella ormai scontata del paziente, del debole o del malato da chi lo aiuta. Al contrario. Parlo di quella forma di dipendenza dove chi aiuta diventa dipendente dall’aiutato: può essere un medico, uno psicologo, un facilitatore, un insegnante, un missionario, chi fa volontariato, ecc.
E’ un rischio sottile che va osservato e conosciuto perché una volta visto, non è più pericoloso.
Faccio qualche esempio nell’ambito della psicologia/psicoterapia anche si può estendere a tutte le altre modalità di aiuto.
- Dopo aver tanto studiato e investito tempo, energia e denaro per prepararsi, il professionista si aspetta dal cliente un ritorno in termini di gratificazione e di successo. E finchè il cliente/paziente non migliora sta li ad insistere, a sostenere, a non mollare, in una sorta di “accanimento psicoterapeutico” perché aspetta che gli arrivi la soddisfazione della guarigione, della gratitudine perché lui ha guarito, è stato bravo. Anche se questo non avverrà. Perché? Perché ci sono clienti che hanno la necessità di sabotare l’intervento di aiuto del terapeuta. Stanno lì apposta per dimostragli che è un incapace, che è impreparato, che con lui ha fallito.Questa prima forma di dipendenza non lascia vedere le dinamiche sottostanti che agiscono nella relazione e il terapeuta rimane invischiato e intrappolato nella frustrazione professionale, con costante e lenta perdita di energia, di motivazione, di curiosità intellettuale.
- Poi c’è la dipendenza dal riconoscimento sociale del ruolo. Poiché la società riconosce e gratifica le competenze intellettuali, i titoli culturali e accademici, diventare e sentirsi chiamare “dottore”, aiuta a compensare le proprie insicurezze, le profonde e non riconosciute autosvalutazioni, i probabili irrisolti affettivi e relazionali. Forse in famiglia non è ascoltato né rispettato mentre nel suo studio, seduto davanti a lui c’è il cliente che pende dalle sue labbra, che lo ascolta, lo segue. E a questa importanza si fa fatica a rinunciare.
3. In termini economici poi, bastano una ventina di clienti che lo seguono anche due volte alla settimana per assicurargli una buona e sicura rendita economica soprattutto in quelle forme di psicoterapia dove è prevista la sottoscrizione di un “contratto”. Terapie che durano anni e la seduta saltata viene pagata lo stesso. Si vive facilmente con pochi clienti, sempre gli stessi e lasciarli andare è difficile e molto scomodo perché bisognerebbe affrontare le regole impietose di un mercato competitivo e complesso. Quindi il professionista si tiene queste persone e anche se l’evidenza dice che non ci sono miglioramenti, la si nega con il concetto della “resistenza” che fa il paziente. Il terapeuta fa del tutto per aiutare ma è l’altro che resiste inconsciamente al suo bene.
Questo tipo di relazioni e dipendenze reciproche, la Scuola di Palo Alto le ha chiamate, “doppio legame”. ((Bateson, Jackson, Weaklan, 1961).
Una forma di relazione e di comunicazione che crea un circolo vizioso dove reciprocamente ci si lega in modo perdente. Come avviene di fatto nelle famiglie “schizofrenogene”, dove agisce un doppio linguaggio e una doppia intenzione
Esempio. Coscientemente la mamma dice al bambino “Sono tanto contenta di giocare con te” ma trasmette inconsciamente: ”Ho tante cose da fare, sto perdendo tempo”. Oppure gli comunica: “Mi fa piacere che vai a studiare all’estero, ma inconsciamente trasmette: “Speriamo che non vai. Come farò senza di te”?
Allo stesso modo può accadere che nella relazione d’aiuto coscientemente gioisci della crescita e dell’evoluzione dell’altro ma inconsciamente potresti non esserne affatto contento perché se risolve presto i suoi problemi, tu cosa fai? Come vivi?
Questi “doppi”messaggi consci ed inconsci dicono al paziente che deve sia crescere che restare bambino e a lui in fondo sta bene così.
E come se ne esce?
Smascherando i propri “doppi legami” con una profonda terapia personale, con lo studio costante, l’aggiornamento, l’osservazione e la supervisione possibilmente con altri professionisti che hanno fatto studi diversi. Altrimenti si continua a vedere la realtà dallo stesso oblò.
E se ci sono clienti che vogliono rimanere e insistono nonostante ci sia lo stallo, bisognerebbe facilitare con diplomazia, l’interruzione della relazione. Anche questa è un’ottima forma di terapia che può produrre la rottura di quell’equilibrio, di quell’omeostasi malsana che si è costruita. Si mantiene pulito il cervello e alta la propria performance professionale.
E il cliente? Dovrebbe onestamente riconoscere le sue personali abitudini, le comodità, le pigrizie, gli alibi perché sono accessibili coscientemente e quando chiede un aiuto, essere onesto nelle sue vere motivazioni. E poi sapere che l’aiuto è limitato nel tempo e deve portare ad osservabili miglioramenti.
Come dice il grande Bert Hellinger, fondatore delle Costellazioni familiari spirituali, un valido aiuto deve essere dato: senza paura, senza amore, senza intenzione, senza compassione, senza aspettative. Il terapeuta deve essere libero da tutto e in armonia con il grande destino del cliente.